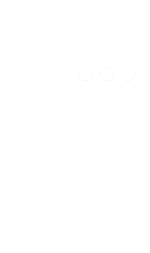La corrispondenza per prigionieri e militari WWII - Introduzione storica
Durante il secondo conflitto mondiale, il nostro paese ha avviato campagne di guerra su diversi fronti, con gli esiti negativi che tutti conosciamo. Ciò nonostante, in occasione delle poche vittorie conseguite sul campo, sono stati catturati dagli Italiani un numero di prigionieri, stimato da diversi autori ed in base alle fonti d’archivio disponibili, dai 140.000 circa del luglio 1942 agli 85.000 circa del settembre 1943. L’elevato numero di prigionieri ha comportato la necessità di allestire, in tempi anche ristretti, numerosi campi di detenzione su tutto il territorio metropolitano, con un notevole impatto in termini organizzativi e logistici. Da non trascurare che gli sviluppi del conflitto in Italia ebbero quale logica conseguenza la necessità di aprire nuovi campi di prigionia e/o di spostare quelli esistenti sulla direttrice sud-nord. Il numero dei campi per prigionieri di guerra in Italia, secondo le notizie raccolte in “www.campifascisti.it” è stimato in 85 e comprende campi di prigionia veri e propri (come il campo di Altamura – Gravina in Puglia P.G. 65), ospedali per prigionieri di guerra (come l’Ospedale di Altamura P.G. 204) e campi di transito (come il campo di Altamura Villa Serena P.G. 51). Questi ultimi erano destinati a raccogliere provvisoriamente, in località lontane dalla prima linea, i soldati fatti prigionieri, in attesa della destinazione definitiva. I campi di transito italiani più numerosi, destinati ai soldati alleati fatti prigionieri in nord Africa, erano in Libia. Da qui, dopo qualche mese, venivano trasferiti in Italia e, dopo lo sbarco nei principali porti quali Brindisi, Taranto o Napoli, avviati in ulteriori campi di transito (citiamo P.G. 66 Capua, P.G. 75 Bari Torre Tresca e P.G. 85 Tuturano). Non si hanno notizie certe di quanti e quando furono i primi soldati nemici catturati, ma è ragionevole presumere che i primi internati furono di nazionalità francese, catturati durante i brevi scontri avvenuti sul fronte alpino occidentale, agli inizi della guerra. Si hanno notizie della presenza di circa 150 Francesi a Fonte d’Amore/Sulmona e di un’aliquota degli stessi presso il Campo P.G. 66 di Capua. Con il proseguire della guerra e l’allargamento dei fronti, numerose altre nazionalità si aggiunsero (Serbi, Croati, Inglesi, Sudafricani, Neozelandesi, Australiani, Indiani, Canadesi, Greci, etc.). Il numero di presenze delle diverse nazionalità tra i prigionieri dipendeva da diversi fattori: la durata della campagna, la regionalizzazione della stessa, la presenza occasionale o meno dei diversi contingenti stranieri, la giurisdizione italiana sul territorio degli scontri. Anche in mancanza di contatti diretti sulla terraferma, l’affondamento di una nave o l’abbattimento di un aereo potevano essere occasioni per fare prigionieri. La campagna di Grecia, dalle alterne vicende, non ha prodotto un numero elevato di internati. Diverso il caso della sia pur breve guerra contro la Jugoslavia: con la conquista della Dalmazia, Montenegro e provincia di Lubiana, dal 1941, si ebbe un consistente afflusso di prigionieri in Italia, spesso catturati, dopo le operazioni belliche vere e proprie, in rastrellamenti successivi anti guerriglia. Indubbiamente, è in Africa Settentrionale, in conseguenza delle continue avanzate e ritirate delle nostre truppe, che furono catturati il maggior numero dei prigionieri alleati, ospitati in campi di transito in Liba e Tunisia, prima di essere trasferiti in Italia. In Tunisia, prima della disfatta del nostro esercito, furono catturati i primi Americani. La giurisdizione territoriale in Africa Settentrionale apparteneva all’Italia e per questo la gestione dei prigionieri alleati, anche catturati dai Tedeschi, fu affidata ai nostri comandi. Diversamente da quanto accadde sul fronte orientale, laddove i soldati sovietici, anche catturati dagli Italiani, ebbero quale destinazione i lager tedeschi. Infatti, non ci sono prove della presenza di prigionieri russi nei campi in Italia.
Sbarco, in un porto italiano, di prigionieri inglesi catturati in Marmarica - Originale Istituto Nazionale Luce - Collezione Nicola Oliva
Cartoline e biglietti postali in franchigia per militari e prigionieri di guerra
Il 27 luglio 1929, a Ginevra, fu firmata la “Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra”. Questa è la versione delle Convenzioni di Ginevra che copriva il trattamento dei prigionieri di guerra durante la seconda guerra mondiale. L’articolo 36 della Convenzione disponeva che ciascuno dei paesi belligeranti fissava periodicamente il numero di lettere e cartoline che i prigionieri di guerra erano autorizzati a spedire al mese. Le lettere e le cartoline dovevano essere inviate per posta seguendo il percorso più breve. Era vietato ritardare la spedizione/consegna o trattenere la corrispondenza per motivi disciplinari. Entro una settimana dal suo arrivo nel campo, e allo stesso modo in caso di malattia, ogni prigioniero doveva essere in grado di inviare una cartolina alla sua famiglia per informarla della sua cattura e del suo stato di salute. Anche tali cartoline dovevano essere inoltrate il più rapidamente possibile e la spedizione non poteva essere ritardata per qualsiasi ragione. Di norma, la corrispondenza dei prigionieri era scritta nella loro lingua madre ma i paesi belligeranti potevano autorizzare la corrispondenza in altre lingue.
Il successivo articolo 37 disponeva che i prigionieri di guerra erano autorizzati a ricevere pacchi postali individuali contenenti prodotti alimentari e altri oggetti destinati al consumo o all'abbigliamento. Tali pacchi dovevano essere consegnati ai destinatari rilasciando anche una ricevuta.
L’articolo 38 della Convenzione del 1929, prevedeva che le lettere ed i pacchi postali indirizzati a prigionieri di guerra, o spediti da loro, direttamente o per il tramite di organismi intermediari, erano esenti da tutte le spese postali nei paesi di origine e di destinazione e nei paesi di transito (franchigia). In caso di riconosciuta urgenza, ai prigionieri doveva essere consentito di inviare telegrammi pagando le relative spese. L’articolo 40 disponeva che la censura della corrispondenza doveva essere effettuata il più rapidamente possibile e che qualsiasi divieto di corrispondenza, ordinato per motivi militari o politici, doveva essere contenuto in un periodo il più breve possibile.
Le disposizioni della Convenzione di Ginevra sulla corrispondenza ed i servizi postali consentono diverse riflessioni ed aprono le porte ad interessanti argomenti di indagine ed approfondimento.
- In primis, viene spontaneo chiedersi: perché preoccuparsi della corrispondenza dei prigionieri di guerra (POW, Prisoners Of War) e dei militari mobilitati in un contesto di morte e distruzione quale quello di un conflitto?
- Quali informazioni si possono ricavare dalla lettura e dall’analisi delle lettere e delle cartoline dei prigionieri di guerra e dei militari combattenti? Quale l’importanza dei pacchi?
- Ancora, quali le modalità organizzative e le difficoltà di un servizio postale in tempo di guerra?
Un ignoto militare italiano del 65° Reggimento di Fanteria scriveva nel 1942 “… ho già avuto occasione di provare la fame, la sete, i pidocchi, il pericolo e l’impressione dura e cruda della morte ma credimi, il più grave disagio che provo è quello di stare senza posta …”.
L’artigliere (gunner) Godfrey Percy Snow, internato presso il campo prigionieri n. 54 (Passo Corese, Fara Sabina), il 02/05/1943 così scriveva alla madre “… Life goes on just the same here from day to day and it is the arrival of letters and parcels from home which go to make landmarks in this era of monotony. …” La vita quotidiana di un prigioniero di guerra è sempre la stessa e solo l'arrivo di lettere e pacchi da casa danno sollievo alla monotonia.
Collezione Nicola Oliva
Per un soldato mobilitato al fronte o per un prigioniero in mano nemica, lontani dalle proprie case da anni, spedire e ricevere lettere e cartoline significa mantenere il legame con gli affetti familiari, avere un motivo per resistere alle atrocità della guerra, costruire un ponte tra la vita serena vissuta prima della guerra e quella futura che verrà dopo la fine del conflitto. Possiamo, quindi, formulare una prima risposta al quesito iniziale. Le nazioni hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra consapevoli dell’importanza della corrispondenza per il morale delle truppe al fronte o in prigionia.
La corrispondenza dei militari al fronte e dei prigionieri, sia pure condizionata dalla censura a cui veniva sottoposta, che imponeva di non divulgare notizie ed informazioni di rilevanza militare o semplicemente critiche nei confronti delle autorità politiche e militari (per i mobilitati al fronte) o di coloro i quali gestivano i campi di prigionia, è utile per raccogliere informazioni sulla vita quotidiana, sulle difficoltà e sulle esigenze degli autori. Il soldato semplice neozelandese Denis Caves, prigioniero presso il campo di transito 51 di Altamura (Villa Serena), scriveva a casa del piacevole clima mite autunnale e della piacevolezza del panorama italiano e delle lezioni di lingua o dei dibattiti informali sotto l’unico mandorlo presente all’interno del complesso.
Il caporale Stanley Littlestone, dal campo 65, in una lettera del 06/12/1942, scriveva dei pacchi della Croce Rossa che arrivavano al campo dall’Inghilterra, dalla Nuova Zelanda e dal Canada, descrivendone in modo dettagliato il contenuto. Confermava l’esistenza sia di uno spaccio interno - dove poter spendere la paga giornaliera di una lira per acquistare prodotti alimentari locali quali cipolle, uva, mele e arance – sia di una piccola biblioteca di circa duecento volumi, da lui curata.
Collezione Nicola Oliva
Nonostante la censura, l’enorme mole della corrispondenza da e verso i militari al fronte ed i prigionieri e le modalità di compilazione della modulistica (oggetto in Italia di copiose direttive e circolari delle autorità preposte) consentì di veicolare anche informazioni rilevanti ai fini militari. Per esempio, per buona parte del conflitto, la posta di militari italiani indirizzata a commilitoni prigionieri di guerra fu spedita senza particolari avvertenze sull’indicazione dell’indirizzo militare del mittente. Solo nel dicembre 1942, con provvedimento tardivo, fu ordinato che le lettere in esame recassero l’indirizzo civile del mittente e non quello militare. Sul punto, è interessante citare lo storico militare G.A. Shepperd che nel suo volume “La campagna d’Italia 1943-1945” Milano 1975, pag. 51, scriveva come il servizio di informazione alleato fosse stato “in grado di ricostruire un quadro notevolmente preciso dell’ordine di battaglia nemico e della dislocazione delle sue unità, grazie al semplice accorgimento di esaminare la posta che veniva avviata attraverso Il Cairo ai 700.000 prigionieri di guerra italiani che si trovavano nei campi del Medio Oriente, dell’India e dell’Africa meridionale e orientale. Le lettere di parenti che prestavano ancora servizio nelle forze armate italiane davano spesso l’indirizzo dello scrivente e in molti casi rivelavano dove era dislocata la sua unità. Anche quando la censura militare italiana cancellava queste indicazioni, si riusciva a rimuovere l’inchiostro di china, per poi rimetterlo, prima di far proseguire la lettera al destinatario. Le informazioni sulla dislocazione delle forze italiane così ottenute si dimostrarono poi molto precise.”. Non è da escludere che cartoline e lettere, apparentemente dal contenuto consueto, potessero nascondere messaggi in codice o scritti con inchiostri simpatici. La stessa spedizione in esenzione da tasse postali (franchigia), prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1929, soddisfaceva certamente le esigenze di semplificazione ed agevolazione ma anche quella di escludere che si potessero nascondere messaggi sotto i francobolli richiesti usualmente per la spedizione. Infatti, per le fattispecie escluse dalla franchigia, come per lungo tempo la posta aerea, gli organi di censura erano costretti a staccare i francobolli per le opportune verifiche, con il conseguente allungamento dei tempi di consegna. Quindi, c’è un altro tipo di approccio alla corrispondenza militare che è quello della ricerca di informazioni spendibili per le finalità belliche da parte, specialmente, degli uffici di censura e controllo dei paesi destinatari.
Timbri ed etichetta di censura italiana e inglese (da Stanley Littlestone cit. Collezione Nicola Oliva)
Le cartoline postali distribuite ai soldati mobilitati italiani durante l’ultimo conflitto hanno assolto anche al compito di essere veicoli di propaganda. Dal dicembre 1940 ebbe inizio, appunto, sul fronte interno, l’attività della propaganda. A tal fine, vennero distribuiti diversi tipi di cartoline in franchigia che, a mezzo di disegni, slogan, motti o messaggi del regime fascista, aventi come destinatari i soldati e le rispettive famiglie, irridevano il nemico, esaltavano il valore italiano ed elogiavano il risparmio dei consumi a favore dei combattenti. Talvolta la parte della cartolina postale occupata da tali messaggi era tale e tanta da ridurre in modo significativo lo spazio a disposizione del mittente. Ecco degli esempi.
Immagini da internet
Figura 1. Immagine cartolina da internet
Figura 2., Figura 3. Cartoline militari (Fronte) da Collezione Nicola Oliva
Considerazioni diverse devono essere fatte per i pacchi della Croce Rossa indirizzati ai prigionieri o per i pacchi spediti dalle famiglie ai militari al fronte. Generi alimentari, vestiti, prodotti per l’igiene personale e di uso comune, specialmente per i prigionieri, costituivano il principale sostentamento. Spesso i pacchi non venivano consegnati al destinatario ma venivano razionati ed il contenuto suddiviso tra i POW, proprio per sopperire alle lacune delle forniture ordinarie di cibo e materiale ai campi. La Convenzione di Ginevra ammetteva e disciplinava le modalità di verifica del contenuto dei pacchi da parte degli organi di censura e disposizioni di dettaglio si pronunciavano sul peso dei pacchi, sulle modalità di confezionamento, specialmente degli alimentari, su quello che si poteva spedire oppure no. Con riferimento al servizio postale militare italiano, ad esempio, ricordiamo il divieto di spedire giornali o periodici ai soldati al fronte, nel timore che venissero inseriti messaggi e per l’impossibilità degli addetti alla censura di poter effettuare verifiche sistematiche. Curiosa e tragica è l’eccezione a tale regola, decisa nell’autunno del 1942, su iniziativa dello Stato Maggiore del Regio Esercito, per i militari dell’8^ Armata in Russia. Fu consentito l’invio di giornali di seconda mano di soli quotidiani politici italiani, raccolti e controllati da Enti del P.N.F., “sia per proteggere le varie parti del corpo dal freddo, sia per usi igienici”. L’utilizzazione di carta di giornale a protezione dal freddo è una conferma della inadeguatezza del vestiario delle truppe italiane durante la campagna di Russia.
Sebbene diverse negli stili e nei colori, le corrispondenze dei prigionieri di guerra nel secondo conflitto mondiale sono sostanzialmente simili nei contenuti, perché disciplinati dalle norme di attuazione derivanti dall’adesione alla sopra citata Convenzione di Ginevra del 1929.
La prima corrispondenza dei soldati catturati dal nemico è proprio la comunicazione alla famiglia del nuovo status di prigionieri di guerra. Le cartoline italiane, di colore celeste, sono simili a quelle alleate e recano sul retro le informazioni essenziali che il prigioniero è tenuto a dare. Il testo è prestampato bilingue (italiano/inglese). Sul fronte, in un piccolo rettangolo viene riportata l’indicazione di “Postage free”, cioè spedizione gratuita. Sono state utilizzate, per le stesse finalità, anche cartoline caratterizzate dall’utilizzo di soluzioni grafiche, come gli esagoni, che richiamano le franchigie in uso ai militari italiani. Tali cartoline di cattura, sempre di colore celeste, iterate tramite la Croce Rossa di Ginevra, hanno un testo che reca più frasi bilingue (italiano/inglese) ove si danno informazioni sullo stato di salute e su come corrispondere in futuro. Per facilitare la comprensione del prigioniero nell’uso bilingue delle indicazioni, la prima lingua utilizzata è l’inglese, anche nello stesso cartiglio e nell’esagono di destra del fronte. La frase “nei prossimi giorni sarò trasferito in un campo per prigionieri del quale vi comunicherò l’indirizzo: soltanto allora potrò ricevere la vostra corrispondenza e rispondervi”, conferma che non vi furono, tranne rarissime eccezioni, scambi epistolari fra i prigionieri alleati e l’esterno durante la permanenza nei campi al di fuori del territorio metropolitano.
Esempio 1: Cartolina cattura prigioniero indiano. Riproduzione ammessa da AICPM Posta Militare 114 2010.
Esempio 2: Cartolina cattura bilingue con esagoni Croce Rossa. Riproduzione ammessa da AICPM Posta Militare 114 2010.
Esempio 3: Cartolina cattura prigioniero italiano Croce Rossa. Egitto, Aprile 1941. Collezione Nicola Oliva.
La presenza di soluzioni grafiche simili e degli esagoni, secondo alcuni studiosi, consente di annoverare le cartoline postali italiane per prigionieri della seconda guerra mondiale fra le franchigie militari. Altri, invece, ritengono che debbano essere catalogate separatamente. Esistono diverse tirature di cartoline per POW su sfondo bianco ed esagono di destra su sfondo nero. Il primo tipo reca l’indicazione del mittente solo in italiano e con l’indicazione puntuale dell’ubicazione del campo poiché, agli inizi, mancava l’attribuzione del numero al campo ed il codice di Posta Militare. Il secondo tipo di tali cartoline, il più diffuso, reca l’indicazione del mittente trilingue – italiano, inglese e cirillico e non compare più il nome della località del campo ma solo il numero (es. Campo P.G. 65) ed il numero di P.M. di riferimento (es. 3450). Quest’ultimo, durante la guerra, è stato utilizzato sia per individuare una particolare area di competenza degli uffici di posta militare (è il caso del Campo 65/P.M. 3450) sia i singoli uffici di posta militare costituiti presso le grandi unità (es. comandi di divisione) del Regio Esercito, dislocati sui vari fronti di guerra. Tali cartoline, inizialmente, recavano al retro uno spazio completamente bianco, che ne consentiva l’utilizzo intero per la scrittura. Siffatta soluzione non rispondeva alle esigenze della censura militare e, per questo, si provvide a lasciare al retro solo una metà da scrivere, prima con una divisione indicata a mano e non prestampata, poi con l’apposizione di timbri che dividevano lo spazio utile da quello riservato alla censura. Si conoscono diversi tipi di timbri. I più diffusi sono due. Il primo reca l’avvertenza in inglese “To avoid delays in censorship please write short and clear letters”, con lo scopo non solo di separare gli spazi ma anche di agevolare la lettura del testo da parte del censore che significava aumentare la probabilità e la celerità della consegna al destinatario. Il secondo reca la scritta “Space non available for correspondance. Card subject to withdrawl if used”, con finalità meramente di separazione di spazi. Quest’ultimo può essere rappresentato da un grosso timbro rettangolare con riquadro che occupa interamente lo spazio non disponibile alla corrispondenza o da un timbro lineare, di dimensioni più ridotte, che si aggiunge all’altro sopra indicato, sempre di tipo lineare. Infine, si optò per la soluzione più logica della predisposizione a mezzo stampa di una linea divisoria e delle frasi di divieto in inglese. Analoga soluzione fu utilizzata sul retro delle cartoline alleate per i prigionieri italiani con avvertenze del tipo “Ad evitare che questa cartolina venga distrutta è assolutamente vietato scrivere testo su questo lato”.
Figura 1. Cartolina (fronte) in italiano con nome del campo in chiaro (Fonte d'Amore) e senza codice di Posta Militare - Riproduzione ammessa da AICPM Posta Militare 114 2010
Figura 2. Cartolina (fronte) in tre lingue ed indicazione numerica del campo (P.G. 65 Altamura) con codice di P.M. 3450 scritta da J. L. Carr il 23.06.1943 - Collezione Nicola Oliva
Particolare del retro della cartolina della Figura 2, scritta da J. L. Carr, riservato alla censura - Collezione Nicola Oliva
Come si può facilmente immaginare, le cartoline consentivano di scrivere solo una decina di righe, visto che, solitamente, metà dello spazio al retro doveva essere lasciato vuoto per la censura. Così, fu concesso di utilizzare biglietti postali stampati appositamente per i prigionieri. Quest’ultimi hanno le dimensioni di un foglio di quaderno, talvolta dalla carta molto sottile, munito di linguella e ripiegabile in tre parti, sul cui esterno è stampigliato lo stemma sabaudo con fasci accanto alla scritta “Posta di prigioniero di guerra” e nella terza parte, che rimane sul retro, le righe stampate con l’indicazione del mittente. In questo caso le lingue estere utilizzate sono l’inglese ed il francese. La parte interna del foglio (composta in genere da 24 righe) poteva essere utilizzata interamente per scrivere mentre, con avvertenza stampata sulla parte esterna, si ammoniva di non scrivere il testo della corrispondenza sull’esterno del biglietto postale. Su di essi non vi è esplicita indicazione di franchigia ma, siccome questa spettava in ogni caso ai POW, essi sono sempre spediti senza affrancatura, salvo i casi di utilizzo della posta aerea. I biglietti postali per prigionieri di guerra sono stati stampati (secondo Bettazzi/Pasquini in AICPM Posta Militare 114 2010 cit.):
- dalla tipografia Mantellate di Roma con ordinativo ministeriale 1343 del 01/12/1941 per 300.000 copie;
- dall’Istituto Poligrafico dello Stato con due distinti stock del 1942 numerati come 5104278 e 6100164;
- dalla società Etruria di Roma con l’ultima tiratura su ordinativo ministeriale n. 343 del 23/01/1943.
Le varie tirature differiscono per la grammatura della carta ed i caratteri di stampa, come, ad esempio, per la scritta “Posta di prigioniero di guerra”, che presenta, talvolta, caratteri più grandi e più marcati, ma l’impostazione grafica è sostanzialmente la stessa, considerato che trattasi di modulo ufficiale realizzato su indicazione ministeriale.
Particolare “Ist. Poligr. Stato 5104278 Roma 1942-XX” da biglietto postale Stanley Littlestone, cit. – Collezione Nicola Oliva
Esempio Tip. Mantellate Roma. Biglietto postale Hubert Hubbard 10/03/1942. Collezione Nicola Oliva
Esempio società Etruria. Biglietto postale Hubert Hubbard 28/04/1943. Collezione Nicola Oliva
Il ruolo della CRI nella corrispondenza nella seconda guerra mondiale
“Interned but in touch” (lett. Internato ma in contatto) è il titolo significativo di un breve articolo, sulla posta dei prigionieri di guerra, apparso sul numero di Aprile 2019 della rivista “Royal Mail Philatelic Bulletin”. Come sopra già evidenziato, solo nel corso della seconda guerra mondiale, dopo la Convenzione di Ginevra del 1929, trovarono applicazione le disposizioni relative alla corrispondenza dei prigionieri di guerra, ratificate dalla maggior parte dei paesi belligeranti. La Croce Rossa Internazionale ha avuto un ruolo centrale nello sforzo di mantenere aperto un canale di comunicazione tra i militari mobilitati e i prigionieri in mano nemica e le rispettive famiglie. In Italia, con la penisola divisa in due, la C.R.I. ha reso possibile anche lo scambio di notizie fra parenti divisi dal fronte. A tal fine, era disponibile il cosiddetto Mod. 3, trilingue in italiano-francese-inglese, in vendita presso gli uffici postali, sia nel Nord sia nel Sud Italia, al prezzo di 15 lire, comprensivo di un buono numerato per la risposta. Tale modulo era stampato su carta sottile, per contenere al massimo il peso, non richiedeva l’affrancatura ed era indirizzato alla Croce Rossa Internazionale di Ginevra. Naturalmente bisognava indicare i dati del mittente e del destinatario; erano ammesse al massimo 25 parole, sia per la domanda sia per la risposta, aventi ad oggetto solo le notizie strette riguardanti la famiglia. Tale corrispondenza viaggiava cumulativamente in pacchi. Come si può facilmente immaginare, i tempi della censura, le condizioni dei trasporti e le vicende del conflitto, la difficoltà stessa di individuare il destinatario, richiedevano anche dei mesi per ottenere un riscontro. I congiunti senza notizie dei propri parenti all’estero potevano scrivere alla Croce Rossa Internazionale a Ginevra che faceva indagini, avvalendosi anche di veri e propri reparti specializzati per la ricerca dei combattenti prigionieri, rispondendo quanto prima. All’uopo, fondamentale era il rispetto della citata Convenzione di Ginevra che obbligava la “potenza detentrice dei prigionieri” a notificare alla stessa C. R. I. l’avvenuta cattura dei combattenti, le loro generalità, specificando lo stato di salute e la località di internamento. Dopo l’8 Settembre 1943 la C. R. Italiana si è alacremente impegnata per acquisire notizie sui militari italiani deportati in Germania. Oltre al servizio postale, la C. R. si è occupata anche della gestione di vaglia e telegrammi (questi ultimi a pagamento) e, soprattutto, della spedizione dei pacchi postali, il cui contenuto, si ribadisce, era spesso vitale per i prigionieri di guerra. Per questi tre servizi, a differenza delle semplici lettere e cartoline, era necessario conoscere con certezza l’ubicazione del campo di prigionia, le generalità ed il numero di matricola del prigioniero. Come sopra già rilevato, per l’inoltro dei pacchi vi erano particolari prescrizioni e divieti: dalle modalità di confezionamento, al peso massimo consentito, al divieto di inviare generi deperibili o contenitori di vetro, ecc. I medicinali potevano essere inviati solamente attraverso la C.R.I. e direttamente da ditte farmaceutiche legalmente riconosciute. In caso di perdita del pacco postale non erano ammesse richieste di indennità. Sull’argomento, sono qui illustrati esempi e documentazione dell’epoca.
Esempio di Modello-3 Croce Rossa - Collezione Nicola Oliva
La Red Cross Britannica e la St. John Association pubblicavano un giornale mensile “The Prisoner of War” distribuito gratuitamente alle famiglie, ove si davano notizie sulle visite periodiche ai campi di prigionia. Era una preziosa fonte di informazione anche sui sistemi postali, con eventuali suggerimenti per evitare disguidi e disservizi. Nel numero del mese di giugno 1943, per esempio, si davano indicazioni sulla tipologia dei libri che potevano essere spediti ai prigionieri e quelli vietati.
Libri recenti di argomento tecnico o contenenti mappe, libri che criticano il Nazismo e il Fascismo, libri di autori ebrei o antologie che contengono opere di autori ebrei, erano vietati - Collezione Nicola Oliva
Figura 1: Lettera pubblicata sul numero di giugno 1943 del "THE POW" – Testimonianza diretta del ruolo della Croce Rossa. Un prigioniero sudafricano del Campo 65 aveva ottenuto il permesso dagli Italiani di scrivere un libro sulla vita del campo, da pubblicare dopo la guerra ed il cui ricavato sarebbe stato devoluto alla Croce Rossa, in segno di gratitudine per ciò che aveva fatto per loro. Collezione Nicola Oliva
Figura 2: Esempio di una cartolina per prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana (Modello 37 - fronte). Immagine da internet
Cartolina (retro) Collezione Nicola Oliva
Nel Campo P.G. 65 c’era un ufficio postale abbastanza grande, gestito dai britannici, diviso in due sezioni, una per la posta dei prigionieri in uscita ed una per quella in entrata. Sui tempi lunghi e sulle difficoltà della consegna della posta la testimonianza diretta del Caporale J. L. Carr del 23.06.1943: <Mail receiving is bad from all directions. Same with personal parcels.> <La ricezione della posta è pessima da tutte le direzioni. Lo stesso vale per i pacchi personali.>. Nel numero di Aprile 2019 della rivista “Royal Mail Philatelic Bulletin è stata pubblicata un’altra cartolina ed una breve biografia di guerra del caporale Carr. Egli fu un ingegnere reale in servizio nella Field Company 232. L'intera compagnia, incluso Carr, fu catturata durante la battaglia di Gazala, ad ovest di Tobruk in Libia, il 1° giugno 1942, venti giorni prima della resa delle truppe alleate alla divisione panzer di Rommel a Tobruk, il 21 giugno. I registri della War Office Casualty Section riportano che Carr fu ferito a Gazala, essendo stato annoverato tra le vittime il 1° luglio. Carr fu tra i prigionieri del Campo 65 che furono trasferiti in Germania, dopo l'invasione alleata dell'Italia, presso lo Stalag 4f, Hartmansdorf Chemnizt, dove rimase per il resto della guerra.
Cenni sulla posta militare nella seconda guerra mondiale
L’organizzazione del servizio di posta militare durante il secondo conflitto mondiale è argomento vasto ed interessante. Garantire il servizio di posta per i militari mobilitati ed i prigionieri di guerra era qualcosa di estremamente complesso perché molteplici erano le questioni logistiche, le criticità e le difficoltà che, però, non hanno impedito la movimentazione di milioni di corrispondenze da e per milioni di uomini. Si accenna brevemente, con particolare riferimento all’esperienza italiana, agli aspetti principali, ognuna delle quali necessita di approfondimenti specifici. Mentre nel caso della prima guerra mondiale il servizio di posta militare fu mobilitato solo all’ultimo momento, all’entrata in guerra dell’Italia nel giugno 1940, il servizio postale militare era già sufficientemente funzionante grazie alla sopravvivenza delle strutture e all’esperienza maturata in occasione di conflitti e campagne precedenti (guerra in Etiopia, intervento in Spagna ed occupazione dell’Albania) ed alla mobilitazione già avviata allo scoppio della guerra nel settembre 1939.
- In primis fu creato e, nel tempo, più volte modificato, un apparato di uffici, gerarchicamente articolato e con l’attribuzione di compiti e responsabilità, produzione di norme, prescrizioni ed istruzioni, a valenza interna o erga omnes (tariffe, franchigie, limiti di importi o di peso, etc.).
- Al vertice della struttura gerarchica fu posta la Direzione Superiore P.M. che operava attraverso le Direzioni Postali d’Armata che, a loro volta, sovrintendevano ai singoli uffici e sezioni staccate dell’armata stessa. Gli Uffici di Concentramento, che operavano giorno e notte per lo smistamento della posta, rappresentavano, invece, l’anello di congiunzione fra l’organizzazione postale civile e quella militare. La base operativa era costituita dagli Uffici di Posta Militare che provvedevano all’accettazione, allo smistamento ed al recapito delle corrispondenze ed alla preparazione dei dispacci (cioè dei sacchi, dei pieghi o pacchi di posta) diretti agli uffici di concentramento. Essi potevano operare anche con sezioni distaccate o servizi di posta volante effettuati con automezzi.
- L’estensione geografica del conflitto e dei fronti, unitamente alle alterne vicende belliche, imponevano continui spostamenti o creazione o soppressione di uffici e, spesso, anche la dispersione di documenti e materiale.
- Il problema principale, da diversi punti di vista, era quello dei trasporti (su gomma e su rotaia, marittimi, aerei): distanze da coprire, strade non battute dal deserto africano alle steppe ghiacciate della Russia, insufficienza dei mezzi, interruzioni di linee, avversità atmosferiche, etc.
- Organizzazione degli uffici di censura per il controllo della posta interna e di quella da e per l’estero.
- Disposizioni, sempre più restrittive per mantenere il segreto militare: per esempio, la sostituzione degli indirizzi in chiaro dei reparti con i codici di posta militare, l’uso di timbri ed annulli anonimi e così via.
- Stampa e distribuzione di cartoline e biglietti postali ma anche dei valori e del materiale occorrente per gli uffici.
- Individuazione dei servizi in franchigia (in esenzione) e di quelli a pagamento. Organizzazione del servizio di accettazione e recapito pacchi. Istruzioni agli addetti ed agli utenti.
- Il reclutamento e la formazione del personale assegnato al servizio in esame, in prevalenza ufficiali o agenti postali dell’amministrazione civile militarizzati con gradi diversi, a seconda dei profili e dei ruoli di responsabilità ricoperti, a supporto dei quali erano comandati militari semplici con compiti di manovalanza o di scorta.
A conferma del ruolo strategico della continuità e della stabilità dei servizi postali nella seconda guerra mondiale, significativo è il contenuto di una Circolare urgente del 18.07.1940 a firma dell’allora Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. Roatta, nella quale si legge <Il servizio postale è – dal punto di vista morale – il più importante fra tutti i servizi. I Capi di Stato Maggiore ed i Capi Ufficio dei Comandi di Raggruppamento Alpino se ne debbono occupare personalmente, e, ripeto, ne sono personalmente responsabili.>.
Nicola Oliva
Associazione Campo 65 – 28.02.2021
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Bibliografia e fonti (notizie ed immagini)
- Collezione Nicola Oliva.
- “Campo 65 La memoria che resta” Associazione Campo 65, settembre 2020.
- “Posta Militare e storia postale” Rivista dell’Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare, numeri 114/115_2010.
- “La posta militare italiana nella seconda guerra mondiale” Cadioli – Cecchi, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, Roma 1991.
- “Royal Mail Philatelic Bulletin” Volume 56, No.8, April 2019.
- “Catalogo Ales Posta Militare” a cura di Fernando Ales, Edizioni Scientifiche Tecniche – Roma.
- “The Prisoner of War”, Red Cross and St. John War Organisation, London, June, 1943.
http://www.crialtipiani.it/cri/
https://www.ilpostalista.it/_seconda.htm